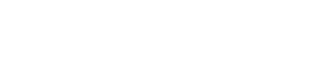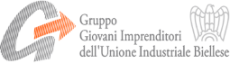Sviluppo della cultura d'impresa - News - 10/07/2014
1864-2014/ 150 anni di industria, industriali e società nel Biellese
1942
Sfogliando lo "Annuario generale d'Italia dell'Impero e dell'Albania", pubblicato dalla ditta "Fratelli Pozzo" di Torino, si può ricostruire una mappa virtuale industriale di Biella e del Biellese. Malgrado lo stato di guerra, la città e le comunità del circondario si dimostravano vive dal punto di vista produttivo, anche in settori diversi da quello tessile laniero. Si tratta di attività speciali, a volte di nicchia e spesso più artigianali che propriamente industriali, che in molti casi andarono scomparendo per sempre negli anni successivi. Limitando l'orizzonte alla sola Biella, ecco i fratelli Azario in via Umberto (oggi via Italia) che producevano candele di cera e steariche, "La Lavandina" in costa di Riva preparava detersivi, Dino Aglietta a Pavignano costruiva carri e carrozze, la "I.S.I.A.B" di Luigi Costa era specializzata in inchiostri, la "Giovanni Arecchi e Figlio" di via Orfanotrofio era un'officina per bilance e strumenti di precisione, dei ventuno fabbricanti di mobili, due, Filippo Tognoletto e la "S.A. Mobilificio Biellese", offrivano anche quelli "artistici" e solo Lidio Migliore quelli "per ufficio", Luigi Castello fabbricava sci in via La Marmora, Giovanni Coggiola produceva soda in via Sant'Eusebio, Giuspepe Angelico modellava turaccioli e oggetti in sughero, la "S.A. Nicolini e Robiolio" distillava vermuth, tre aziende tessevano tappeti: i fratelli Blotto Baldo in via Avogadro, la "Cotonifici Riuniti F.lli Poma" in via XX Settembre e Bismarck Peraldo al Piazzo, la "Ferraro Celso & Figli", la "Romersa Virgilio e C." e Mario Motta si dedicavano alla produzione di "paste alimentari", i cugini Garella a quella di piastrelle di cemento, esistevano quattro saponifici, Giovanni Cossutta assemblava scope, Alfredo De Ambrosis rubinetti, la "Rivoira G." generava ossigeno, Sestilio Melani era il titolare della "Casa del Ricamo" e in quattro ("Manifattura Debernardi", Attilio Vescovi, Alfredo ed Emilio Trombetta) producevano "nastri di carta misuratori" ecc.
1943
All’1 e 33 della notte tra il 12 e il 13 luglio 1943, duecento cinquanta aerei della RAF iniziarono una tremenda azione di bombardamento su Torino. I bombardieri inglesi, nell’arco di poco più di un’ora, sganciarono “763 tonnellate di bombe, che provocano la morte di 792 persone e ingenti danni a edifici, infrastrutture e stabilimenti industriali”. Biella e il Biellese non subirono bombardamenti aerei di sorta, ma alcuni biellesi vissero comunque, direttamente o indirettamente, l’esperienza di sentire, nel buio, cadere la morte dal cielo. Anche alcune aziende biellesi, che avevano stabilimenti produttivi o filiali commerciali in città bersaglio delle incursioni alleate, patirono perdite notevoli. E’ il caso della ditta “Francesco Maggia e Figlio” che nel 1930 aveva aperto a Torino, in via Mantova 19. Quella fabbrica di maglieria fu completamente distrutta durante quella tragica notte. I Maggia, originari di Pettinengo, pur mantenendo attivo l’antico opificio sul rio Tamarone fino al 1936 (la storica sede in quell’anno fu trasferita, purtroppo, nel nuovo stabile torinese), erano sempre stati votati ad allargare i propri orizzonti imprenditoriali e ad aggiornare i sistemi produttivi. Furono tra i primi a utilizzare le caldaie a vapore nel Biellese e già alla fine dell’Ottocento le esportazioni arrivavano in Turchia, in Sud Africa e in India. Nel 1898 Francesco Maggia, in società coi compaesani e concorrenti Bellia, avviò il “Fabbricone” di Vercelli impiegando ben duecento operaie. Durante la Grande Guerra, sulla scorta delle costanti commesse militari, i Maggia acquisirono il vetusto maglificio Vigna di Occhieppo Superiore (tuttora in attività) e aprirono un’unità produttiva in via Tadini a Milano (chiusa nel 1930 per concentrare i macchinari a… Torino). Ma le bombe al fosforo made in England non fermarono la caparbietà made in Biella dei Maggia che, tra il 1944 e il 1945, ricostruirono e rimisero in funzione i telai e le di Torino.
1944
"In die Räume der Firma Poma in Biella wird eine wehrwirtschaftlich wichtige Firma verlegt werden. Wegen der Bedeutung der Sache wird gebeten, die sofortige Freimachung der Räume von dem Lacklager Agna und der Lumpensammelstelle zu veranlassen..." ovvero: "Nei locali della Ditta Poma in Biella, verrà trasferita una importante Ditta di difeso-economica [sic]. A cagione della importanza della cosa, si prega di provvedere allo immediato sgombro dei locali del magazzino Agna e del magazzino raccolta-stracci...". Con questo ordine perentorio diramato al Comune di Biella dal Comando Militare Germanico in data 23 novembre 1943 e attuato nelle settimane successive comincia la parentesi biellese della Piaggio. La fabbrica di Pontedera era stata distrutta dai bombardamenti alleati e l'azienda, con buona parte del personale, era stata traslocata a Biella. Nel 1944, tanto nei saloni del Cotonificio Poma quanto in quelli adiacenti dello Stabilimento Meccanico Biellese, l'attività prevalente fu quella della rifinitura delle eliche per i bombardieri e i caccia tedeschi, come i famigerati Junkers Ju 87, meglio noti come Stuka, o i Messerschmitt. Ma la presenza della fabbrica di Enrico Piaggio a Biella è nota per un altro, più lieto e importante motivo. Non appena finita la guerra e, con essa le consegne imposte dalla Luftwaffe, in quelle stesse officine gli ingegneri D'Ascanio, Spolti, Corsini e Carbonero progettarono e misero a punto i prototipi dei veicoli a due ruote denominati MP5 "Paperino" e MP6, dai quali fu sviluppata la "Vespa". Ecco perché è nel contesto industriale biellese che si riconosce il luogo di nascita dello "scooter che motorizzò l'Italia".